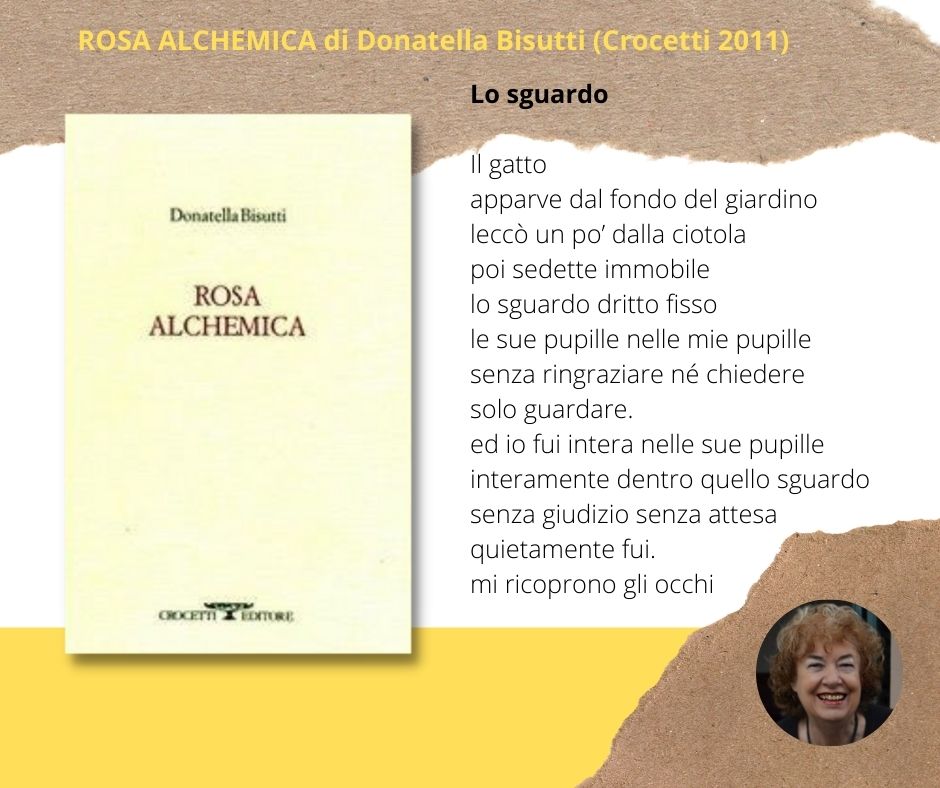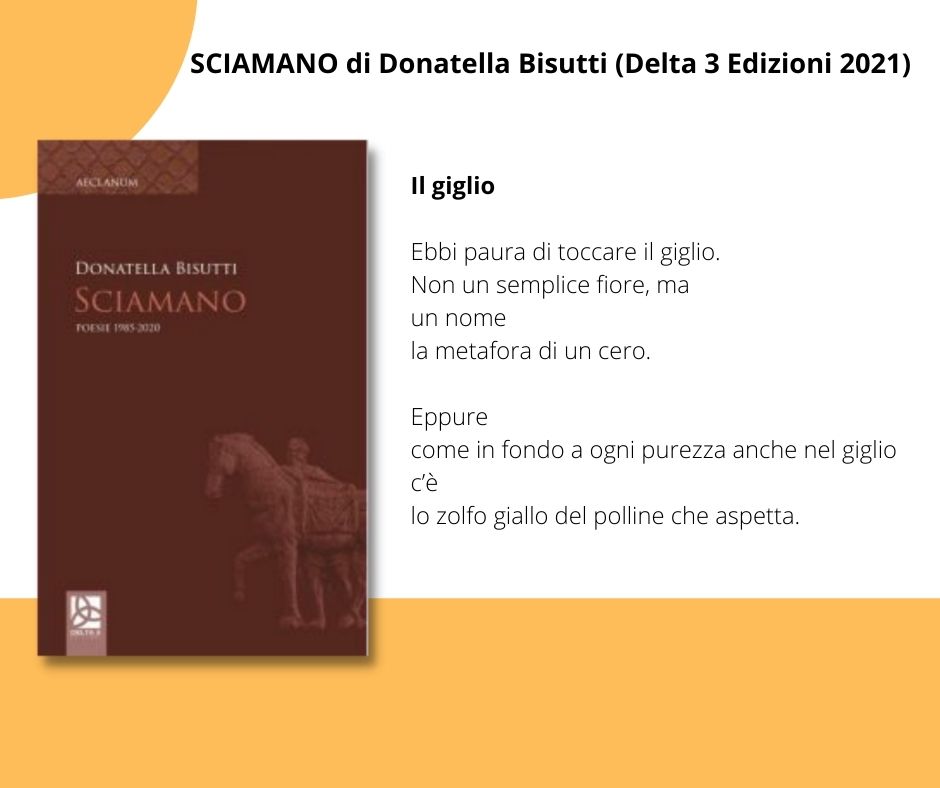“Erano le ombre degli eroi” la recensione di Marzia Minutelli sulla rivista Atelier
Vi faccio parte della bellissima recensione al mio libro “Erano le ombre degli eroi” di Marzia Minutelli pubbicata sul numero 115 della rivista Atelier diretta da Giuliano Ladolfi.
La «novella Tebe» di Donatella Bisutti
Marzia Minutelli
[…] il mito è un linguaggio, un mezzo espressivo – cioè non qualcosa
di arbitrario ma un vivaio di simboli cui appartiene, come a
tutti i linguaggi, una particolare sostanza di significati che null’altro
potrebbe rendere.
CESARE PAVESE, Dialoghi con Leucò, Avvertenza
A breve distanza dalla ricapitolativa sillog e di versi Sciamano (Gottaminarda, Delta 3, 2021) e dalla raccolta di aforismi Ogni spina ha la sua rosa (Bologna, Pendragon, 2022), Donatella Bisutti dà alle stampe una composizione poetica di largo respiro e di alte ambizioni, Erano le ombre degli eroi (Firenze, Passigli, 2023, prefazione di Eugenio Borgna), la cui stesura l’ha tenuta impegnata per quasi un quadriennio, dal dicembre del 2015 fino all’agosto del 2019 1. Opera tipologicamente affatto eccentrica nel panorama della lirica italiana contemporanea, il cui antecedente più prossimo sembra potersi ravvisare in The Waste Land di T.S. Eliot e nel suo «mythical method»2, il testo si configura come un (post)moderno poema epico, articolato in cinquantadue atti distribuiti in sette parti di diversa ampiezza che correda, secondo il modello eliotiano, una fitta congerie di dotte note esplicative. Il racconto bisuttiano – che di poesia narrativa propriamente si tratta, con intercalate otto sequenze dialogiche di stampo teatrale arieggianti la tragedia attica – fa perno sul più fosco e frastagliato tra i complessi mitologici greci, quello afferente alla «città nefasta» (p. 17) per antonomasia di Tebe, che, ripercorso nella sua totalità (dalle peripezie del fondatore Cadmo e della sorella Europa all’infando dramma familiare di Laio, Giocasta ed Edipo fino alla spedizione fratricida di Polinice e dei suoi sei compagni e alla conclusiva guerra degli epigoni)3, viene liberamente rivisitato e rifunzionalizzato nei suoi significati simbolici per farne una «grande rappresentazione metaforica del mondo in cui viviamo»:
Ho guardato […] alla realtà di oggi attraverso la lente di un Mito spezzato e ricomposto da
molti frammenti e al tempo stesso ho guardato al Mito come all’incunabolo della nostra realtà:
una spola fra un lontanissimo passato e il presente che, se mi indusse a reimmergermi nelle
oscure, enigmatiche, contraddittorie profondità del Mito, mi spinse anche a stravolgerlo
(Prologo, p. 9).
Il mito ellenico, dunque, come uno specchio grandangolare in cui si riflettono le molteplici insorgenze socio-economiche e antropico-ambientali dei nostri giorni, siano esse l’occidentale «orgasmo mercantile» (p. 45) delle multinazionali e il cinismo delle relative speculazioni finanziarie, le migrazioni coatte degli ultimi della terra e le nuove forme di schiavitù, le discriminazioni etniche e l’erezione di muri, la violenza perpetrata nei confronti di donne e minori, le derive onnipotentistiche della scienza, le insidie dell’automazione e dell’intelligenza artificiale, le cruente tecniche di macellazione animale e gli allevamenti intensivi, il consumismo cieco e gli abusi alimentari, la devastazione dell’ecosistema nei suoi mille risvolti (l’estrazione sconsiderata dell’«Oro Nero»4, l’iperproduzione di rifiuti, lo scialo delle risorse idriche, le calamità naturali correlate alla progressiva desertificazione del pianeta).
Ma, nel fantasmagorico gioco di rifrazioni di questo visionario oeil de sorcière non sono solo le storture e le scabrosità dell’epoca odierna a versarsi negli stampi leggendarî del paradigma tebano, ma è quel medesimo luogo archetipico a subire una deformazione prospettica attualizzante, popolandosi di tunnel e di grattacieli, di cinema e di night, di pizzerie e di fast food, di treni e di autobus, di ambulanze e di furgoni,di ruspe e di container, di droni e di bazooka, di computer e di smartphone, di carte di credito e di «lattine di coca cola» (con le iniziali del nome del marchio ostentatamente in caratteri minuscoli, p. 117).
Il monstrum primigenio, gli abominî esemplarmente connaturati alla materia antica grondano i loro putridi umori sul presente, ma, mentre in quel metatempo ancestrale a compensarli e a redimerli soccorreva – polarità complementare che attiene all’ambivalenza fondante della dimensione mitica – il culto della bellezza, l’attuale umanità «ha smessodi credere alla Bellezza e ha perso la capacità di sublimare l’orrore» (Prologo, p. 10).
Se gli dèi, abitanti atarattici e fatui di un oltremondo di cartapesta, appaiono ormai soltanto quali simulacri indistinti («Non erano più gli dei, erano le pallide ombre degli dei», p.135), gli eroi, smarrita la loro scintilla divina, ossia la prometeica fiducia nelle virtù e nelle facoltà intrinseche alla dignitas hominis, si sono ridotti a propria volta a «ombre», come il titolo stesso del libro addita. Così, abbrutiti nel corpo e isteriliti nello spirito, si presentano i cittadini di questa distopica Tebe-mondo al centro dell’Atto L, per l’appunto l’eponimo dell’opera, in una pagina tra le più coraggiosamente impietose e incisive del poema:
Ininterrottamente
entrano ed escono dai grandi centri commerciali
caricature delle statue di Apollo, dell’uomo
di Leonardo di là da venire,
immagini di una bruttezza abusata.
Portano sandali di plastica su piedi deformi se è estate
o scarpe da jogging consumate d’inverno,
jeans strappati, shorts troppo larghi su varici pelose, ripugnanti
rotoli di grasso escono da sotto
casacche di tela a fiori,
portano giacche a vento nere col cappuccio, ridicoli berretti
su teste rasate, calve, precocemente
grigie, hanno brutti nasi, guance cadenti
accanto a loro donne secche sbiadite obese con enormi
sacche di cibo appese al braccio
Le ombre degli eroi
Incessantemente vanno e vengono escono dagli uffici
entrano nelle toilette
a volte si suicidano sotto i vagoni della metropolitana
e questo è sgradevole perché causa ritardi nei trasporti
che irritano gli altri in attesa
a volte sterminano la famiglia moglie e figli piccoli
a volte strangolano le loro donne che vogliono lasciarli
a volte presi da malinconia
sfogliano album di foto di quando andavano a scuola
e non si riconoscono in mezzo ai loro compagni (pp. 123-124).
L’andamento prosastico dei versi, volutamente scabro e disadorno (uno stile discorsivo asciutto e crudo contrassegna d’altronde l’intera opera, a eccezione dei tre intermezzi denominati «favole sulla Bellezza» e dei già ricordati quadri scenici, dove a tratti si elegizza in vibranti accensioni liriche5 o si impenna solenne o trenodico, a mimare i moduli, rispettivamente, delle sezioni patetico-descrittive dell’epica e del dramma classici), ben si conforma alla rappresentazione di questi individui alienati, insulsi e senza scopo, «massa miserabile» in balìa dei disegni di annientamento dei «signori di Tebe» (p. 125), sprezzanti e feroci plutocrati che nell’ombra ne muovono i fili:
Per la loro bruttezza e miseria,
meritano di scomparire.
Sono come formiche,
e non ne proveremo più pena
che a distruggere un formicaio.
Un groviglio nero (p. 126).
Denuncia – «grido di allarme» e non lamentazione, per espressa dichiarazione dell’autrice6 – di uno status quo dai toni deliberatamente algidi e impersonali, dunque, che informa nondimeno un acre moralismo di stampo giovenaliano (ma a fare questi versi certo concomita l’indignatio dantesca, ché nella prima cantica della Commedia a paradigma per eccellenza di città degenerata assurge appunto la polis beotica)7 e al contempo trascorre una sotterranea pietas per i vinti e i reietti, siano essi illustri personaggi (specialmente femminili)8 del mito od oscuri figuranti della storia e della cronaca contemporanee, tali gli extracomunitarî «schiavi» stagionali «[…] piegati sui campi / a raccogliere i frutti sacri della terra / nella piana sterminata / prima che sorga l’alba»:
Li hanno scaricati da vecchi furgoni
corpi ammassati schiacciati uno sull’altro
nell’afrore acido dell’estate
come animali portati al macello
gettati sulla piana a raccogliere i frutti d’oro rosso
i pomi d’oro del Giardino delle Esperidi
ogni giorno riempiono cesti e casse
il sugo fiammeggiante dei frutti è tutt’uno
con il sangue delle loro dita (Atto XL, Gli Schiavi, p. 93).
Ma l’apocalissi prossima ventura, l’annunciata catastrofe di questa tragedia della ὕβρις e dell’avidità umane che, definitivamente infranta l’armonia tra essere e cosmo, balena l’annullamento stesso della poesia e della sua funzione civilizzatrice9, può forse essere ancora stornata se nell’explicit dell’ultimo Atto i bambini, pur non riuscendo a scorgere nel cielo velato gli dèi che in extremis tentano di tornare «in aiuto ai mortali» (p. 135), dopo aver assaggiato la «mucillagine disgustosamente dolce» (p. 136) pianta dalle nuvole sulla terra desolata, ridono. Il mondo dunque, giusta l’utopico auspicio che fu già di Elsa Morante, verrà salvato dai ragazzini?
NOTE
1 Prima, quindi, dell’emergenza pandemica da Covid-19, le cui risonanze psicologiche, contrariamente a quanto sembrerebbe
lecito supporre (leggendo ad esempio i vv. 65-69 dell’Atto L, p. 125: «Ma lasciamo che muoiano da soli / […] / […]
soltanto di inedia, malattie / che non è colpa nostra se non possiamo curare»), non hanno perciò concorso alla concezione
del testo.
2 In «Ulysses», Order, and Myth, saggio sul romanzo joyciano pubblicato su «The Dial» nel 1923, lo scrittore afferma che il
criterio in questione «è semplicemente un modo di controllare, ordinare, e dare forma e significato all’immenso panorama
di futilità e di anarchia che è la storia contemporanea» (THOMAS STEARNS ELIOT, Opere 1904-1939, a cura di Roberto
Sanesi, Milano, Bompiani, 2001, p. 646).
3 Non senza disinvolti sconfinamenti nell’àmbito di altri miti classici, ad esempio nel componimento consacrato all’orto
delle Esperidi, pur sempre implicato con il ciclo tebano per il tramite di Eracle, nativo appunto della città beotica (Atto
XXXIX, Il Giardino incantato), o in quello incentrato sulla secondogenita del re dell’Argolide Agamennone, immaginata
vittima dello stupro paterno (Atto XLVII, Elettra), o ancora della storia antica, ad esempio nel testo che vede protagonista
– pur innominato – il condottiero Epaminonda, promosso a campione emblematico della lotta democratica all’imperialismo
(Atto XLII, Il Comandante e l’Impero).
4 È il titolo dell’Atto XLIII, dedicato al petrolio, «sangue oscuro della Terra»: «Ma oggi i nuovi Tebani / più non erigono
templi ad Ade / non più temono di fissare i suoi occhi impietosi / ed estraggono quel sangue oleoso da pozzi profondi
/ scavati / a ferire la terra. // Non temono le Gorgoni che abitano / nell’estremo occidente, presso il regno dei morti, /
e il nero sangue velenoso simile a quello / che zampillò dalla testa tranciata di Medusa, / lo vendono più caro dell’oro /
lo chiamano oro. Ma l’oro / ha lo splendore del sole / […] / Questo oro invece è nero / e quando si infiamma / ha
bagliori sinistri. / Nero è il suo colore di morte» (pp. 101-102).
5 Penso in particolare ai diafani movimenti iniziali dell’Atto XXVI, Selene, e del già ricordato Atto XXXIX, Il Giardino
Incantato, dove trema, carduccianamente, un desiderio vano della bellezza antica.
6 Nell’intervista concessa a Francesca Rita Rombolà per il blog Poesia e Letteratura, consultabile al seguente link: https://
bisutti/.
7 Né andranno dimenticati gli exempla tebani allegati nel Purgatorio e nel Paradiso. Superfluo ricordare che la citazione che
intitola queste pagine è attinta dall’apostrofe del canto XXXIII dell’Inferno, la celeberrima invettiva scagliata, in coda
all’episodio del conte Ugolino, contro «Pisa, vituperio delle genti» (v. 79), definita appunto «novella Tebe» (v. 89).
8 Tale l’Elettra-Ofelia, suicida dagli sciolti capelli inghirlandati di fiori, del già ricordato Atto XLVII.
9 Cfr. nell’Atto LI, Simili agli Dei (Seguito), lo scambio di battute tra CHAIRMAN ed EXECUTIVE: alla domanda del primo «E
cosa ne faremo dei poeti?» segue questa risposta del secondo: «Come un’erba nefasta li estirperemo / perché predicano
la libertà e l’insurrezione» (p. 128).