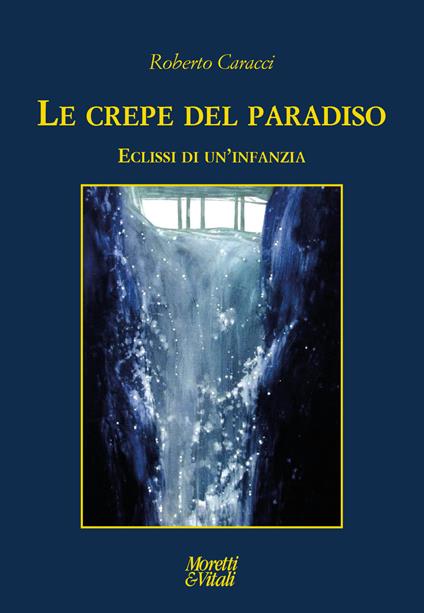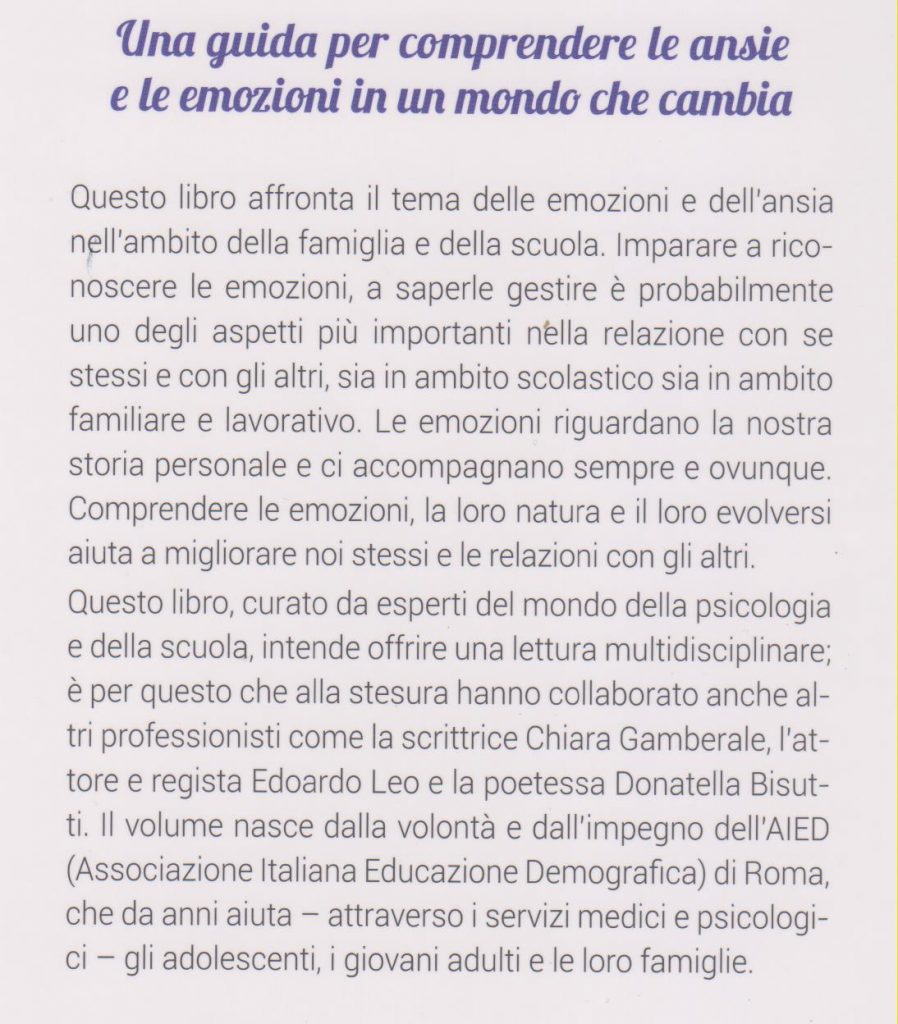Poeti in ombra, ovvero I poeti e la fama (pubblicato su I Limoni)
Di seguito il mio saggio “Poeti in ombra, ovvero I poeti e la fama” pubblicato su I Limoni, Annuario della Poesia in Italia nel 2023, a cura di
Francesco De Nicola
Poeti in ombra
(ovvero I poeti e la Fama)
di Donatella Bisutti
Ogni poeta ha un suo rapporto personale, a volte bizzarro, con
la Fama. Ma questo rapporto, prima di essere personale, può
essere condizionato, favorito, od ostacolato, prima di tutto da
ragioni familiari, ma anche sociali, storiche, politiche. Come
succede per il denaro, ci sono, anche per quanto riguarda la
Fama, i ricchi e i diseredati. C’è chi la riceve in qualche modo,
come la ricchezza, per via ereditaria, e il suo è quasi un de-
stino: infante, gioca a cavalluccio sulle ginocchia di qualche
nome iconico della letteratura amico di casa, di qualche fa-
moso editore che già lo prende a benvolere e domani lo pub-
blicherà senza che lui debba fare il minimo sforzo, di qualche
proprietario di importanti testate giornalistiche, oppure nasce
in una famiglia di scrittori famosi: la Fama aleggia intorno alla
sua culla e già sembra spalancare le porte al neonato. Ma biso-
gna pur dire che a volte – rare volte – questo può essere anche
un handicap: c’è infatti anche chi proprio per questo dubita
di essere all’altezza e del casato letterario gli capita in sorte
solo il peso e l’inibizione, soffre del confronto, si rattrappisce,
si fa piccolo ed evita di intraprendere una carriera di poeta.
Conviene anche notare tuttavia che, curiosamente – ma ci sarà
pure una ragione – la poesia è molto meno ereditaria, chissà
perché, della musica, o della pittura, e perfino della narrativa.
Filtra difficilmente attraverso il DNA.
La Fama è comunque, per definizione, una nozione non
privata, ma pubblica. Ogni epoca ha, per la Fama, e anche
per la Fama dei poeti, un suo criterio, un suo metro, una sua
misura. Perciò può anche succedere, al contrario, che la Fama
si posi sul capo di chi è nato povero, diseredato, diverso, di-
sgraziato, escluso, e proprio per questo diventa in certo modo,
socialmente, un vessillo, una bandiera di tempi nuovi, diversi.
Prima di essere una questione personale, quindi, la Fama,
ancora più che un fatto sociale, è una questione che ha a che
fare con la Storia. E la Storia significa il Tempo. Ci sono poeti
che nascono fuori tempo. In ritardo o in anticipo. Più che al-
tro in ritardo. Anche se mi viene in mente almeno un caso di
poeta “in anticipo”: Emilio Villa, che anticipò la neoavanguar-
dia, ma nessuno volle mai riconoscerglielo, e fu anzi messo
al bando, ghettizzato, ignorato. Vero è che sembra avesse un
caratteraccio. O il caratteraccio gli era venuto di conseguen-
za? Così ci volle che gli venisse finalmente dato un premio,
quand’era ancora vivo ma malato – e non poté ritirarlo – da
una giuria da me presieduta e significativamente non costitu-
ita da poeti, ma da artisti, scultori e pittori, uno psicologo di
fama come Mauro Mancia e un’attrice come Ottavia Piccolo.
La Moda è la sorella frivola, incostante, apparentemente
superficiale della Storia. Perciò la Fama e la Moda, anche per
quanto riguarda la poesia, vanno a braccetto. Perché non esi-
stono parametri sicuri, oggettivi, con cui pesare una poesia
(anche se Pound aveva detto che il poeta, “come il porco”,
si può pesare, ma “dopo morto”). Così come non esiste un
criterio oggettivo che ci dica, fuor da ogni dubbio, se è giusto
che una gonna sia lunga, o se deve essere corta, un paio di
pantaloni a zampa di elefante o a tubo, una giacca attillata
oppure ampia: nella moda si decide al momento quello che
va bene, oppure no. E appena si è deciso, ecco che si cambia
idea. Anche nella poesia, in fondo, succede lo stesso. Anche se
affermarlo potrà sembrare blasfemo. Chi si presenta a un rice-
vimento con una gonna lunga quando usano ormai le gonne
corte, sarà considerato una persona demodée e inelegante. Cosi
un esempio di poetessa fuori moda, perché fuori tempo, cioè
in ritardo, anche se a suo modo elegantissima, è stato quello
di Giovanna Bemporad. Giovanna Bemporad ha scritto del-
le poesie bellissime, che sarebbero piaciute a Baudelaire e ai
poètes maudits, poesie dense di simboli e trasudanti una sen-
sualità ambigua, perfette nella forma, troppo perfette in anni
in cui la neoavanguardia – quella anticipata da Emilio Villa,
che nel frattempo era arrivata – scardinava il linguaggio e se
ne infischiava dello stile, gettava fiaccole incendiarie sulla per-
fezione, sghignazzava sui simboli e buttava nella spazzatura gli
endecasillabi, i sonetti, le assonanze. La Bemporad è diventata
famosa come traduttrice, in moderni splendidi endecasillabi,
dell’Odissea, ma le è stata pervicacemente negata la Fama in
quanto poetessa in prima persona, uno strazio per lei insop-
portabile, che si è portato dentro – ma lo esternava anche mol-
to – fino alla tomba.
Ma come, si dirà, si può abbassare la Poesia, arte del su-
blime e dell’eterno, al livello di qualcosa di frivolo come la
Moda? Paragonare i sonetti ai merletti? Un’ode a un abito da
sera? Eppure, senza nulla togliere alla poesia, nel cui valore
anche metafisico, anche oracolare, sciamanico, io credo pro-
fondamente, nel mio saggio La poesia salva la vita mi sono
sforzata di mostrare come essa si occupi anche di bidoni della
spazzatura e di calzini bucati, come possa andar per via anche
più povera e nuda della filosofia, come sia qualcosa con cui,
facendola scendere da pretenziosi piedestalli, possiamo avere a
che fare nel quotidiano, in cucina, nel sottoscala, in cantina,
tutti i giorni. Come possa essere anche proletaria e diseredata.
E come tale la dobbiamo anche saper trattare. Miracolo della
poesia, uno dei tanti: far brillare la spazzatura come un dia-
mante. Il che, tra parentesi, è riuscito benissimo a un poeta
come il genovese Nicola Ghiglione.
Basta riflettere un attimo, sfogliare una storia o un’antolo-
gia letteraria per rendersi conto che a ogni pie’ sospinto la po-
esia, femmina e come tale incostante, ha cambiato look e im-
provvisamente qualcosa che fino ad allora era stato “di moda”
improvvisamente ha cessato di esserlo. Perciò: bisognava essere
simbolisti o avanguardisti? manieristi o surrealisti? ermetici o
crepuscolari? stilnovisti o metafisici? poetare in rima o in verso
libero? scrivere in prosa d’arte o in versi?
Ma come si può allora coniugare tutto questo con un pre-
teso valore “assoluto” della poesia? Allora la poesia cos’è? Ap-
partiene alla Storia o all’Eternità? Secondo me la si può pa-
ragonare al mare, che in superficie ha a volte ondine appena
increspate, altre volte cavalloni, onde lunghe, vortici e correnti
ma, sotto quella sua superficie di continuo cangiante, nella
profondità è immobile e sempre uguale a se stesso e ospita con
imparzialità mostri e meraviglie. Quindi, per esempio, anche
la poesia della Bemporad potrebbe riaffiorare al termine di
un’ondata impietosa che l’ha sommersa.
Così questo già si può dire, sul tema dei “poeti in ombra”:
che l’ombra per quanto riguarda i poeti è spesso intermittente.
E che quasi tutti i poeti – anche i più famosi – attraversano
periodi in cui sono “in ombra”, la loro fama ha delle eclissi
in cui la dimenticanza vela le loro pagine come l’ombra della
Terra ricopre di un cono d’ombra la faccia della luna. E queste
eclissi possono durare anche un secolo o più.
Non ne è stato esente nemmeno Dante, che non di rado
fu oggetto di scarsa considerazione da parte di critici italia-
ni e stranieri. Un letterato influente come il cardinale Pietro
Bembo, che, nel Cinquecento, si propose di codificare la lin-
gua italiana, escluse Dante dal novero dei modelli letterari,
privilegiando invece il Petrarca. Nemmeno la Controriforma
fu favorevole al sommo poeta, di cui venne addirittura mes-
so all’indice, per ragioni politiche, il trattato De Monarchia.
Nel Seicento e nel Settecento, con l’eccezione di Giambattista
Vico (il suo Giudizio sopra Dante è del 1729) Dante fu ad-
dirittura ignorato, se non spregiato, e solo il Romanticismo
riaccese l’interesse nei suoi confronti. Anche in tal caso questo
dipese più dalle circostanze e dalle ragioni della Storia che dal-
la critica letteraria, poiché il suo messaggio politico si sposò
agli ideali del Risorgimento attraverso Foscolo e Mazzini. Ma
bisogna aspettare l’Ottocento perché il De Sanctis dia al poe-
ta una consacrazione che ormai si può considerare definitiva.
Oggi Dante e la sua Commedia sono saliti agli onori anche
dei fumetti e dei videogiochi, se questo sia un bene non si sa.
La Bemporad quindi può ben aspettare, il tempo può essere
infine dalla sua parte.
In Italia però il cono d’ombra si stende anche troppo fa-
cilmente sui poeti morti. Se si tratta di poeti antichi, illustri,
in qualche modo consacrati, quest’ombra non si vede, sembra
non esserci: ma, a guardar bene, tranne qualche rara eccezio-
ne, forse solo il Petrarca, di fatto nessuno li legge, se non per
ragioni di studio, e quindi non solo l’ombra ma addirittura il
buio li circonda. Dell’Ottocento c’è una sola grande eccezio-
ne, grazie anche alla scuola, ma forse anche al fatto che siamo
tutti sempre più inclini al pessimismo, se non alla dispera-
zione: il Leopardi. Più vicini a noi, sempre molto grazie alla
scuola, il Pascoli, ondivago il d’Annunzio, e poi naturalmente
Ungaretti, Quasimodo, Montale la triade perfetta del Nove-
cento, tre poeti diventati inseparabili nelle citazioni anche se
nella vita non si potevano vedere.
Però che cosa succede quando ci avviciniamo di più ai tem-
pi nostri? Quando non ci sono eredi, muse ispiratrici, disce-
poli fedeli a sostenere la memoria? La morte del poeta diventa
per lo più un nero abisso in cui egli sprofonda insieme ai suoi
testi. Di Alfonso Gatto, grande poeta, fino a qualche anno fa
si poteva trovare pubblicato solo un suo libro di poesiole per
bambini. Poi finalmente gli è stato dedicato dalla Mondadori,
che di fatto detiene i diritti, un Oscar, non mi risulta un ben
più prestigioso Meridiano. Chi si ricorda di Lucio Piccolo,
di Sinisgalli, di Cattafi? Della Margherita Guidacci? Il poeta
morto, contraddicendo forse Ezra Pound, è da noi normal-
mente oggetto di un periodo di oscurità più o meno lungo,
che in molti casi tende a diventare definitivo. Ben lo sapeva
Montale, che è stato un poeta anche ironico, e che predispo-
se, prima di morire, una sorta di caccia al tesoro, che affidò
alla sua ultima ispiratrice, Annalisa Cima, la quale ogni cin-
que anni doveva aprire una busta che conteneva degli inediti.
Così per alcuni anni, ogni cinque anni, Montale ritornava in
vita, era presente, si faceva sentire, era quasi come se non fosse
morto. Ma non tutti sono così previdenti.
La previdenza di Montale è una dimostrazione del fatto che
tuttavia anche dopo la morte non tutto è affidato al caso, che
anche in questa circostanza il poeta può fare qualcosa per non
entrare o restare in ombra e che, più in generale, lasciare degli
eredi è indispensabile, anche se capita purtroppo che gli eredi
di sangue approfittino della scomparsa del caro e famoso estin-
to per regolare in silenzio dei conti lasciati in sospeso, magari
impedendo l’accesso all’archivio che racchiude preziose testi-
monianze e manoscritti inediti. Per contro, ci sono vedove che,
loro sì, hanno vissuto fino ad allora una vita nell’ombra, spes-
so sfruttate come segretarie e soffocate dall’illustre coniuge, le
quali, dopo la sua dipartita, diventano attivissime e arrivano a
vivere finalmente una gloria in prima persona, pur sempre glo-
ria riflessa, ma anche illuminata da qualche riflettore. A volte
le vedove sono due, una ufficiale e una clandestina, che si con-
tendono la fama del morto, il quale però in genere, non aven-
do scelto in vita, prudentemente, fra l’una e l’altra, ha pensato,
sempre per prudenza, che fosse più sicuro e più facile che tut-
to il prezioso materiale che lo riguardava restasse affidato alla
protezione dei lari domestici e quindi anche dopo la morte la
lotta fra la vera e la pretesa vedova rimane una lotta impari,
ancorché questa concorrenza, e qualche pettegolezzo, possano
alimentare quelle maldicenze che della fama sono l’auspicabile
coronamento. Si dà poi anche il caso del poeta la cui fama era
in parte dovuta all’esercizio di un potere che gli consentiva di
elargire benefici a una vasta schiera di cortigiani: in questo caso
la sua morte sarà seguita dal dispettoso silenzio di coloro che
hanno visto venir meno una disponibile mangiatoia poetica.
Ci sono tuttavia, in questo rapporto fra il poeta e la morte,
come sempre, anche vistose eccezioni, anzi vistosi rovescia-
menti: nessuna fama in vita e grande fama dopo la morte. La
prima di queste eccezioni cui viene fatto di riferirsi è quella
di Antonia Pozzi, la quale non aveva soltanto rinunciato alla
fama, non avendo mai pubblicato, bensì alla stessa vita, ma
la cui poesia oggi travalica il ristretto gruppo degli specialisti
per arrivare eccezionalmente a un pubblico relativamente va-
sto. La sua vicenda fa in qualche modo pensare a quella della
Dickinson, che a sua volta non pubblicò mai in vita (anche
se sembra che avrebbe voluto farlo, ma non ci riuscì), visse
da reclusa e oggi è una delle poetesse più famose al mondo.
Un’altra eccezione è quella di Alda Merini, che anche dopo la
morte continua a essere letta, pubblicata, citata e a fare noti-
zia. Anche nel caso di Alda Merini non si può dire che avesse
cercato la Fama: sono stati gli altri a cucirgliela addosso. In
lei c’erano gli elementi per farne un personaggio e ne è stato
fatto un personaggio. Lei ci si prestava volentieri, perché era
sufficientemente istrionica, ma i suoi eccessi non erano finti.
Tuttavia, se la Pozzi non si fosse uccisa per un amore infeli-
ce, se suo padre non fosse stato una figura oppressiva e castran-
te, se la Dickinson non avesse vissuto chiusa nella sua stanza
vestita di bianco come una suora della poesia, se la Merini non
avesse pubblicato una sorta di diario del periodo di reclusio-
ne in manicomio pochi anni dopo l’approvazione della legge
Basaglia, la loro poesia avrebbe destato, desterebbe oggi altret-
tanta attenzione? Lo stesso si può dire per un’altra poetessa
suicida, Sylvia Plath. Allora ci si può chiedere: la poesia è un
testo? solo un testo? o vale in quanto è la voce di un’anima? la
traduzione in linguaggio di un’avventura umana?
Infinite domande suscita dunque il tema dei poeti in om-
bra. Un tema pressoché infinito, perché si pone da tante di-
verse angolazioni.
Certo oggi viviamo in un’epoca in cui il personaggio conta
spesso più di un testo. E allora molti che vogliono acquistare
fama di poeti cercano, più che di lavorare sulla scrittura, quel
personaggio di inventarselo. E così ecco quello che finge di
essere un barbone e vive in una baracca, quello che si mette un
cappello di paglia uguale a quello di Hemingway, quello che
professa a gran voce di voler restare in ombra e acquista per ciò
stesso grande visibilità.
Ci si può chiedere anche: oggi in che cosa consiste la fama
di un poeta? Si tratta di un giudizio di valore letterario o è
sempre di più un’immagine che si forma in un caleidoscopio
di continuo roteante davanti ai nostri occhi?
Questi due aspetti per ora rimangono ancora un po’ sepa-
rati, ma è evidente che sta sempre più venendo meno il riferi-
mento di un giudizio critico sicuro, affidabile, come accadeva
ancora qualche decina di anni fa, per cui chi scriveva poteva
dirsi che, se il suo lavoro fosse stato preso in considerazione
da tale o tal’altro critico, egli avrebbe potuto legittimamente
aspirare a ottenere un suo posto, più o meno importante, nel
panorama letterario e questo panorama letterario si sarebbe
magari dilatato fino a divenire storia della letteratura. Oggi
è sempre meno così, il riferimento critico è diventato sem-
pre più vago, casuale, inconsistente, sostituito spesso com’è da
amicizie e appartenenze, da recensioni ottenute in cambio di
favori, mentre, in una sorta di circo barnum senza controllo
e in continua espansione in cui tutto è sovraesposto, restare
in ombra viene considerato sempre più penalizzante. Perciò
poeti e aspiranti poeti fanno di tutto, per lo più, per acquistare
una fama che non sempre corrisponde a effettivi meriti in una
società dove il successo sui social, che non può essere certo
garanzia di qualità, ingolosisce anche i grandi editori i quali, a
loro volta, pensano spesso più a vendere che a fare cultura. Ed
ecco allora che si mette in moto tutto un sistema di riferimenti
che va dai premi, ai reading, ai festival, alla cronaca e alle varie
apparizioni sui media, soprattutto in quella sorta di salotti che
sono i social: un’attività che richiede da parte dell’interessato
grande impegno di tempo e di energia, così che forse poco
ne resta per la letteratura, e anche una vocazione, più che da
poeta, da promoter, da manager, da addetto stampa. È vero
che anche in passato i poeti, anche i più grandi, frequentavano
i Salotti, ma erano salotti dove, in un sol colpo, si trovavano
riunite le più belle teste dell’epoca e dove si esercitava ad altis-
simo livello l’arte della conversazione. Dagli scambi sui social
deriva invece un certo scadimento di qualità di tanta produ-
zione poetica attuale, un appiattimento verso il basso e perfino
un imbarbarimento della lingua, e soprattutto un’inflazione di
scriventi che si arrogano un titolo di poeta a cui non dovreb-
bero poter pretendere e si impadroniscono di piccole o grandi
posizioni di potere per farlo valere.
D’altra parte questa smania, da parte di persone tutto som-
mato comuni, di emergere, di avere successo, di farsi un nome
attraverso un atto massimamente individuale come la crea-
zione poetica, forse la si può anche capire – volendo trovare
una giustificazione al fenomeno – come una reazione un po’
squallida a un mondo in cui sempre di più assistiamo all’o-
mologazione, alla progressiva cancellazione della persona, non
più individuo ma mero numero, mero codice da digitalizzare.
Chi sono quindi in conclusione oggi i poeti in ombra?
Sono i poeti che per carattere, sfortuna o incapacità di pro-
muoversi non riescono a diventare famosi. Conosco anche
chi, forse un po’ snobisticamente, non vuole diventarlo. A
volte – raramente – si tratta di un rifiuto inconscio. Un caso
emblematico è quello della grande poetessa romana Fernanda
Romagnoli, morta nel 1986 all’età di 70 anni, che raggiunse
tardivamente la fama solo nel 1980, una fama che subito si
spense con la sua morte, come una stella filante, e che, in dieci
anni di faticosi tentativi editoriali, cercai di ravvivare, riuscen-
doci solo in parte, nel 2003, facendola finalmente ripubblicare
da Scheiwiller. Si è trattato però per me più che di lottare con
gli editori, di lottare con la sua anima, con il suo desiderio di
autopunizione, di espiazione per quella che il suo inconscio
certo considerava una colpa, un venir meno ai doveri di una
vita banale di casalinga dedita solo alla famiglia.
Ma ci sono anche poeti in ombra perché per loro essere
in ombra è un destino, magari un non facile destino, forse
addirittura una consapevole scelta. Poeti di cui non farò qui i
nomi, e che mi paiono spesso i migliori che si possano leggere
fra quelli operanti oggi, uno in realtà – di lui farò il nome –
recentemente scomparso, Sandro Boccardi, musicologo, con-
tadino della Bassa Padana nel cuore, che aveva impersonato
Bach in un documentario indossando una parrucca di boccoli
bianchi che al compositore tedesco lo faceva assomigliare mol-
tissimo, come venisse anche lui dal lontano Settecento, autore
di una poesia dal linguaggio attualissimo nella forma musicale
del sonetto. Questi poeti “in ombra” hanno in comune il fatto
di essere, loro sì, quella cosa rara che è un poeta vero.
Che cosa li distingue? Lo starsene appartati, lo scrivere una
poesia metafisica, che riflette cioè un’idea alta dei valori dello
spirito – il che certo oggi è un andare controcorrente e già
questo ne fa dei diversi, degli isolati – , essere quindi “fuori
moda”, incuranti di gruppi e ideologie, privilegiare il silen-
zio esterno e il silenzio interiore, la lettura come ginnastica
dell’anima, la musica, il bosco come natura e come metafora.
Poeti che, da quella prospettiva, scendendo in profondità, ri-
tengono che si possa dar voce anche al dolore, allo spasimo,
all’urlo di Munch, soprattutto alla pietà per la follia dell’uo-
mo che, come una metastasi, divora la nostra vita. Poeti che
hanno una giusta stima di sé unita a una giusta modestia e
sanno mettersi in rapporto con gli spiriti del mondo per lo
più ostili all’uomo, come credevano gli antichi sciamani, poeti
che sono ancora essi stessi un po’ sciamani e credono di poter
dare conto – muovendo dal silenzio – anche del fragore, della
distruzione, dell’allontanamento dalle leggi della Natura, della
progressiva cementificazione della terra, della desertificazione
e delle frane, dell’imbarbarimento della musica, dello snatura-
mento della virtù, dell’annientamento delle anime e dei corpi,
del grottesco e tragico orrore della miseria fisica e spirituale,
di quella angosciante realtà che troviamo nei Canti Civili di
un poeta non accademico, non inserito nel sistema, e pertan-
to vero poeta, poeta in ombra quant’altri mai, e per questo
dimenticato, e per questo da riscoprire e da ricordare, come
appunto è stato Nicola Ghiglione.
COVER_limoni_2023